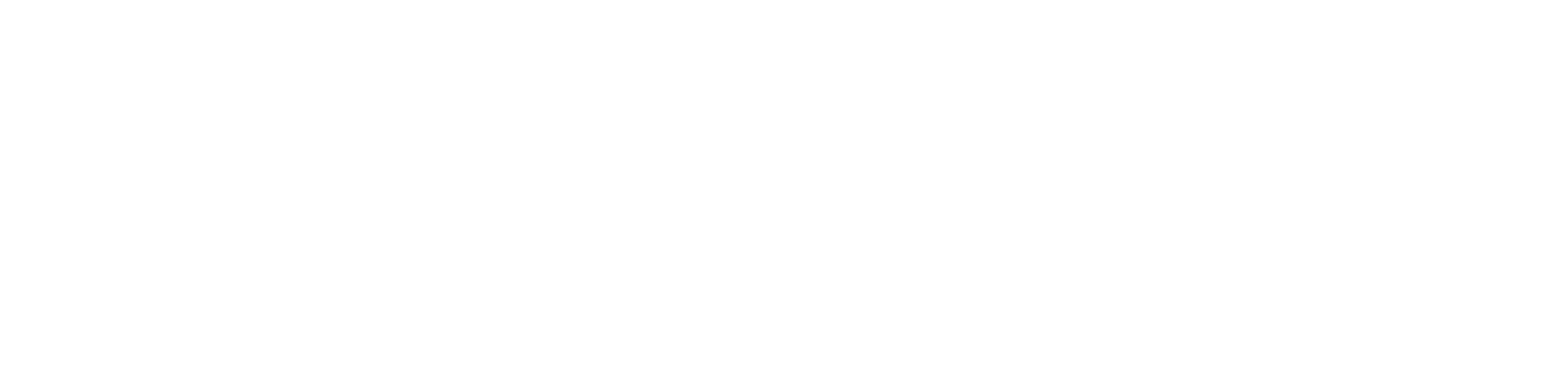La Ratio Formationis ed il Direttorio per il Ministero e la Vita dei Diaconi Permanenti: un percorso da aggiornare
Don Dario Vitali, presbitero della Diocesi di Velletri-Segni, docente di Ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana, consulente del Dicastero per il Clero
Abbiamo ascoltato tante esperienze relative al ministero e alla vita dei diaconi. Serena Noceti ci ha offerto l’orizzonte di riferimento dentro il quale pensare – o ripensare – il ministero diaconale: la Chiesa sinodale missionaria. A me si chiede di indicare una direzione per il futuro, attraverso una rilettura della Ratio Formationis e del Direttorio per il Ministero e la Vita dei Diaconi Permanenti.
Si tratta di due documenti ormai datati – 22 febbraio 1998 –, a firma della Congregazione per l’Educazione Cattolica il primo, della Congregazione per il Clero il secondo, preceduti da una Dichiarazione congiunta delle due Congregazioni.
Così si apriva la Dichiarazione congiunta: «Il diaconato permanente, ripristinato dal concilio Vaticano II in armonica continuità con la Tradizione antica e con i voti specifici del Concilio ecumenico di Trento, in questi ultimi decenni ha conosciuto, in numerosi luoghi, forte impulso e ha prodotto frutti promettenti, a tutto vantaggio dell’urgente opera missionaria di nuova evangelizzazione». La Dichiarazione sottolinea come «i due documenti rispondono ad una necessità largamente avvertita di chiarificare e regolamentare la diversità di impostazione degli esperimenti fin qui condotti, sia a livello discernimento e di preparazione, sia a livello di attuazione ministeriale e di formazione permanente».
Non vorrei limitarmi a rileggere i due documenti nell’orizzonte del ripristino del diaconato come «grado proprio e permanente della gerarchia ecclesiastica» voluto dal concilio Vaticano II (cfr LG 29); mi pare necessario sottolineare da subito la stretta corrispondenza tra il modello di ministero proposto dal concilio e il modello di Chiesa dentro il quale si inscrive. Lo richiamo con una citazione di Lumen Gentium che richiama la festa della Cattedra di San Pietro che oggi celebriamo: «Nella comunione ecclesiastica esistono le Chiese particolari, che godono di tradizione proprie, fermo restando il primato della cattedra di Pietro, che presiede alla comunione universale della carità, garantisce le legittime diversità e insieme vigila perché il particolare non solo non nuoccia all’unità, ma anzi ne sia al servizio» (LG 13).
Si tratta di un passaggio fondamentale del capitolo II di Lumen Gentium che spiega il principio di cattolicità del Popolo di Dio. Il Documento Finale della XVI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, recependo l’ecclesiologia conciliare, ha ribadito che la Chiesa è il Popolo di Dio, vale a dire «il soggetto comunitario e storico della sinodalità e della missione», nel quale «la comunione dei Fedeli communio Fidelium) è al tempo stesso la comunione delle Chiese (communio Ecclesiarum), che si manifesta nella comunione dei Vescovi (communio Episcoporum), in ragione del principio antichissimo che “la Chiesa è nel Vescovo e il Vescovo è nella Chiesa” (S. Cipriano, Epistola 66,8). Al servizio di questa multiforme comunione il Signore ha posto l’apostolo Pietro (cfr Mt 16,18) e i suoi successori. In forza del ministero petrino, il Vescovo di Roma è “il perpetuo e visibile principio e fondamento “dell’unità della Chiesa (cfr LG 23)» (DF 17-18).
1. Le scelte del concilio Vaticano II
Il tentativo di armonizzare la storia complessa del diaconato, mettendo in sequenza lineare la Tradizione antica, il concilio di Trento e il concilio Vaticano II, si scontra con i dati della storia e ancora di più della storia del dogma. La richiesta del Decretum de reformatione del concilio di Trento di ripristinare il diaconato nella forma antica non fu mai attuata, perché in realtà tutto l’impianto legato agli ordini minori e maggiori tendeva al suo coronamento nell’ordinazione sacerdotale. Il suddiaconato e il diaconato non potevano che essere ordini di passaggio verso il gradino più alto della scala degli ordini.
Per questo il concilio Vaticano II, al momento di ripristinare il diaconato come «grado proprio e permanente della gerarchia ecclesiastica» (LG 29), ha dovuto rivolgersi alla Tradizione più antica. Come conseguenza obbligata della scelta di affermare che «la consacrazione episcopale conferisce la pienezza del sacramento dell’Ordine, quella che la consuetudine della Chiesa e i Santi Padri chiamano il sommo sacerdozio, la somma del sacro ministero» (LG 21), il concilio ha restituito il quadro degli ordini della Chiesa antica: «In tal modo il ministero divinamente istituito viene esercitato in ordini diversi da coloro che già in antico vengono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi» (LG 28). A partire da qui, il diaconato è stato ripensato come «grado proprio e permanente della gerarchia», fondato sulla ordinazione «non ad sacerdotium, sed ad ministerium», che comunica la grazia sacramentale, in forza della quale i diaconi sono abilitati, alla «diaconia della liturgia, della parola e della carità, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio» (LG 29).
Paolo VI, assumendo il dettato conciliare, promulgò la normativa per tutta la Chiesa, con due motuproprio del 15 agosto 1973: Ministeria quaedam aboliva gli ordini minori e il suddiaconato, introducendo i ministeri istituiti del lettorato e dell’accolitato; Ad pascendum fissava le norme per la restaurazione del diaconato “permanente”. Per quanto la normativa fosse chiara e lineare, Vescovi ed episcopati erano divisi sulla questione: chi era propenso, chi contrario, chi non prendeva posizione.
Mi sia permesso un ricordo: il mio vescovo, Dante Bernini, al momento di ordinare i primi diaconi nel lontano 1980, oppose alla resistenza di molti presbiteri una ragione che allora non capivo fino in fondo e che oggi mi pare illuminante e profetica nella sua semplicità disarmante: «Perché il concilio ci ha consegnato questo dono e abbiamo la responsabilità di valorizzarlo!». Era la fiducia nel discernimento della Chiesa che si era posta in ascolto dello Spirito. È la stessa ragione addotta dalla Dichiarazione congiunta, quando specifica, citando Giovanni Paolo II, che nella scelta dei Padri conciliari «operava misteriosamente lo Spirito Santo, protagonista della vita della Chiesa, portando ad una nuova attuazione del quadro completo della gerarchia, tradizionalmente composta di vescovi, sacerdoti e diaconi».
2. Il quadro proposto dalla Ratio e dal Direttorio
La pubblicazione della Ratio e del Direttorio, il 22 febbraio 1998, vedeva una situazione ormai consolidata. Per quanto in vaste aree del pianeta non fosse stato promosso – soprattutto nelle Chiese di Africa e Asia –, il diaconato era ormai diventato una realtà così vasta dal punto di vista non solo numerico, che era necessario regolare il fenomeno con una normativa omogenea. È questa la finalità dei due documenti.
La Dichiarazione congiunta che funge da premessa alla Ratio e al Direttorio riprende la descrizione del ministero ordinato proposta dal Catechismo della Chiesa Cattolica: «Il sacramento dell’Ordine configura a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. Per mezzo dell’ordinazione si viene abilitati ad agire come rappresentanti di Cristo, capo della Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote, profeta e re» (CCC, 1581).
La Ratio fa riferimento a «una sicura teologia del diaconato», fondata sulla seguente affermazione: «Innanzitutto bisogna considerare il diaconato, come ogni altra identità cristiana, all’interno della Chiesa, intesa come mistero di comunione trinitaria in tensione missionaria. È questo un riferimento necessario nella definizione dell’identità di ogni ministro ordinato, anche se non prioritario, in quanto la sua verità piena consiste nell’essere una partecipazione specifica e una ripresentazione del ministero di Cristo» (Ratio, 4). Il quadro di riferimento ecclesiologico è quello della communio, secondo quanto aveva affermato il Sinodo straordinario del 1985: «L’ecclesiologia di comunione è idea centrale e fondamentale nei documenti del concilio Vaticano II». Evidentemente, un modello di Chiesa universale domandava una corrispondente declinazione universale del modello di ministero, individuata nella ripresentazione del ministero di Cristo. Il Catechismo non faceva altro che riprendere il Codice di Diritto Canonico: «Con il sacramento dell’ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio» (can 1008).
A partire da qui i due documenti hanno rispettivamente sviluppato la normativa rispetto al ministero e alla vita dei Diaconi Permanenti. Non è questo il luogo per riprendere tutti i contenuti dei due documenti. L’importante era individuare i fondamenti dottrinali proposti per il ministero dei diaconi, perché costituisce il discrimine per ogni opera di aggiornamento della Ratio e del Direttorio: l’esigenza di mettere mano a un aggiornamento è tanto più necessaria e urgente, quanto più riguarda i fondamenti teologico-sacramentali. Oggi la questione è totalmente istruita a questo livello. Non si tratta solo di una discussione accademica. È dalla vita della Chiesa che sale questa esigenza, non più dilazionabile dopo che il Santo Padre ha chiesto di studiare il tema, anche in relazione alla questione disputata del diaconato femminile e dopo che il Documento finale dell’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi ha avanzato la medesima richiesta (cfr DF 73).
3. Necessità e urgenza di un aggiornamento
Perché dunque è necessario un aggiornamento? Già la Ratio sottolineava come «la quasi totale scomparsa del diaconato permanente nella Chiesa d’Occidente per più di un millennio ha reso certamente più difficile la comprensione della profonda realtà di questo ministero. Tuttavia non si può dire per ciò stesso che la teologia del diaconato sia senza alcun riferimento autorevole, in completa balìa delle opinioni teologiche. I riferimenti esistono, e sono molto chiari, anche se esigono di essere ulteriormente sviluppati e approfonditi» (n. 3). La direzione verso la quale la Ratio orienta la proposta dottrinale è che «il diaconato viene conferito mediante una speciale effusione dello Spirito (ordinazione), che realizza in chi la riceve una specifica conformazione a Cristo, Signore e servo di tutti» (n. 5). L’affermazione poggia sul presupposto che ciascun ordine è caratterizzato da una specifica partecipazione alla funzione di Cristo-Capo: il Vescovo ripresenterebbe Cristo-Sposo; il presbitero, Cristo-Pastore; il diacono, Cristo-Servo.
Ma, come tutti sanno, Benedetto XVI è intervenuto su questo punto con il motuproprio Omnium in mentem (26 ottobre 2009), modificando la normativa codiciale con l’inserimento di un comma: «Coloro che sono costituiti nell'ordine dell’episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità» (CJC, can 1009, § 3). La ragione del cambio risiede con tutta evidenza nel rispetto della Tradizione, richiamata anche dal concilio Vaticano II per il ripristino di questo grado dell’Ordine: i diaconi sono «ordinati non ad sacerdotium, sed ad ministerium».
Da quel momento una questione che pareva brillantemente risolta è tornata in discussione e le proposte in merito si moltiplicano, anche se è facile individuare due fronti. Da una parte quanti tendono a sminuire la portata del motuproprio e della sua affermazione per difendere non tanto il diaconato, ma l’impostazione tridentina del sacramento dell’ordine; dall’altra quanti lo recepiscono come elemento dirimente, cercando nella formula ad ministerium una soluzione alla discussione sulla natura del diaconato.
In un caso e nell’altro il rischio è di sminuire il diaconato. Se strettamente legato a una comprensione dell’Ordine che fa del sacerdozio la vetta della potestas ordinis, il diacono torna ad essere colui che svolge le parti ministeriali della Messa, con funzioni di supplenza solo quando si dia carenza di sacerdoti. Se pensato sul versante del ministero, finisce comunque sul gradino più basso della gerarchia, in un quadro di subordinazione che risponde più a una logica di potere dei singoli ordini che di servizio al Popolo di Dio. Di fronte a questa polarizzazione, non manca che vorrebbe seppellire la scelta conciliare di ripristinare il diaconato permanente, tornando a uno status quo ante.
4. Recuperare la dimensione ecclesiologica del diaconato
Contro questa tentazione, la via privilegiata per valorizzare il diaconato e custodirlo come dono per la Chiesa è quella di sciogliere il nodo relativo alla sua natura, escludendo ogni interpretazione che lo riduca a un doppione di qualcosa d’altro, o a una funzione minore, comunque ausiliaria e di supplenza, sempre a rischio di essere riassorbita nelle funzioni ministeriali dei presbiteri.
Il punto di partenza di questa via non può che essere il dato fermo della Tradizione: i diaconi sono «ordinati non ad sacerdotium, sed ad ministerium». Mi impressiona come la formula sia stata interpretata in termini riduttivi, quasi fosse un modo per sminuire il ministero diaconale, attraverso il riferimento a un servizio imprecisato e generico. Al contrario, la formula intendeva originariamente una ordinazione «ad ministerium Episcopi», che significa ben di più della diaconia della liturgia, della parola e della carità «in comunione con il vescovo e il suo presbiterio», con la quale il concilio descrive il ministero dei diaconi (LG 29). Il ministero diaconale, in questa linea, viene compreso attraverso un legame speciale con il «principio e fondamento di unità della Chiesa particolare» (LG 23), reso manifesto dal fatto che unicamente il Vescovo impone le mani sull’ordinando.
Per comprendere la formula, bisogna situarla in contesto, tornando alla Chiesa di Padri. Quella Chiesa si concepiva come una communio Ecclesiarum. Pensiamo al concilio di Nicea, di cui stiamo celebrando quest’anno i 1700 anni della sua celebrazione. Quel concilio – ogni concilio ecumenico – è stato manifestazione adeguata la Chiesa, in quanto ogni vescovo ha ripresentato nell’assise sinodale la sua Chiesa, e tutti insieme hanno ripresentato la Catholica. Questa concezione poggiava sul principio già richiamato che «la Chiesa è nel Vescovo e il Vescovo è nella Chiesa» (S. Cipriano, Lettera 66,8). La Tradizione ha interpretato questo legame in chiave di vincolo sponsale (l’anulus) e di cura pastorale (il baculum) tra il Vescovo e la sua Chiesa.
Basta richiamare i tratti salienti di quel modello di Chiesa per capire la straordinaria importanza del ministero diaconale. Il centro della vita di ogni Chiesa era la celebrazione eucaristica, che solo il Vescovo poteva presiedere, in quanto successore degli apostoli, chiamato a trasmettere il Vangelo (1Cor 15,3) e rinnovare il sacramento della Nuova Alleanza (cfr 1Cor 11, 23). Al Vescovo, in quanto garante della successione apostolica, incombeva una doppia azione di cura: del corpo ecclesiale e del corpo eucaristico. Egli doveva garantire al corpo ecclesiale il corpo eucaristico; doveva al contempo curare il corpo ecclesiale perché fosse “in grado” di ricevere il corpo eucaristico, perché tutte le membra erano sane e salde nella comunione. La prima cura era svolta con l’aiuto del presbiterio, che Ignazio di Antiochia chiama «il senato del Vescovo» (Ai Magn., 6,1): la Tradizione ci attesta la presenza necessaria del presbiterio, che da una funzione iniziale di consiglio si è via via sviluppata in una cooperazione con il Vescovo in ambito sacramentale, espressa nel fatto di concelebrare la liturgia eucaristica con il Vescovo. Il presbiterio, che con il Vescovo condivide l’onore sacerdotale, è chiamato soprattutto a garantire al corpo ecclesiale quel corpo eucaristico che comunica la salvezza. Sta qui il senso dell’ordinazione ad sacerdotium.
Ma questo non esaurisce la pienezza del sacramento dell’Ordine del Vescovo, che consiste nella «summa sacri ministerii», da non intendersi tanto come il vertice, ma, alla lettera, la «somma», la composizione nella sua persona della doppia funzione – ad sacerdotium e ad ministerium – che dice la cura che il Vescovo deve avere non solo per il corpo eucaristico, ma anche per il corpo ecclesiale.
5. Un ministero indispensabile
A questa seconda funzione erano dedicati in antico i diaconi: la cura della comunità e di ogni suo membro, in particolare delle membra più fragili e necessitate, vale a dire i poveri e gli ammalati. Si trattava di una cura che garantiva il volto della Chiesa voluta da Gesù: se le comunità primitive si concepivano come quel “resto” vaticinato dai Profeti, quei «poveri di JHWH» nel quali si era compiuta la promessa dello Spirito finalmente donato come “caparra” del Regno, la cura degli ultimi non si riduceva mai a un atto sociale di solidarietà, ma era un atto teologico ed ecclesiale per eccellenza. L’Eucaristia è anticipazione e prefigurazione del banchetto escatologico (cfr Mt 26,29). La parabola del banchetto nuziale (cfr Mt 22,1-14) non è solo un ammonimento, ma un imperativo per la Chiesa delle origini: nell’agape fraterna che costituiva il primo momento dell’assemblea nel giorno del Signore, era il Vescovo insieme ai diaconi a servire la comunità riunita.
Era il servizio alla Chiesa come corpo di Cristo, in particolare alle membra più fragili e bisognose di questo corpo che il diacono doveva compiere, insieme e per conto del Vescovo. Impressiona come nei resoconti della Chiesa dei martiri, vicino al Vescovo ci fossero soprattutto i diaconi. La Chiesa era viva per la loro cura. E sorprende come la moltiplicazione dei ministeri – suddiacono, accolito, lettore, esorcista, ostiario – sia avvenuta per una redistribuzione dei compiti del diacono, tanto era il carico di lavoro che doveva sopportare per venire incontro alle necessità della Chiesa.
Quando ha perso rilievo il ministero dei diaconi? Quando il riconoscimento del cristianesimo come religione dell’impero ha determinato la nascita di una societas christiana, sotto l’autorità diretta dell’imperatore, che ha svuotato un ministero fondato sul compito di curare il corpo ecclesiale e le sue membra più deboli e bisognose. La creazione delle diocesi per unificazione di Chiese viciniori, affidate ai presbiteri in qualità di parroci, ha fatto il resto: ai diaconi non rimanevano che le funzioni esclusivamente liturgiche. Quanto però il loro ministero di cura fosse necessario e imprescindibile lo dimostra il sorgere, nel secondo millennio cristiano, di tante istituzioni e soprattutto ordini e congregazioni religiose dedicate alla carità. Un modello universale di Chiesa favoriva il sorgere di queste forme di servizio ai poveri, agli ultimi, agli ammalati, generalmente configurate a livello canonico dalla Santa Sede come istituti di vita consacrata.
Il concilio Vaticano II ci ha riconsegnato un modello di Chiesa come «il corpo delle Chiese», «nelle quali e a partire dalle quali esiste l’una e unica Chiesa Cattolica» (LG 23). Benché l’uno non sia causa dell’altro, sorprende la concomitanza dei due recuperi: quello della forma di Chiesa come communio Ecclesiarum e quella del diacono come ministero di cui il concilio Vaticano II ha riconosciuto l’importanza e la necessità per la Chiesa. A partire dal fatto che ogni Chiesa locale è «una portio Populi Dei affidata al Vescovo con la cooperazione del presbiterio», emerge non soltanto lo spazio per l’esercizio de una funzione ad sacerdotium, ma quello altrettanto – anzi, ben più vasto – di una funzione ad ministerium, diretto a tutte le situazioni di necessità, di povertà, di bisogno, sulle quali la Chiesa è chiamata a piegarsi per curare le ferite.
Sono convinto che un aggiornamento della Ratio e del Direttorio non possono che passare per il recupero di questa dimensione ecclesiale del ministero diaconale, che rilegge la diaconia della Parola, della liturgia e della carità a partire dall’aspetto complementare rispetto al ministero sacerdotale: curare il corpo ecclesiale in tutti i suoi bisogni. Per la celebrazione eucaristica non è strettamente necessario il servizio ministeriale del diacono: il Vescovo, un presbitero presiedono l’Eucaristia anche senza la sua presenza, in quanto garantiscono il corpo eucaristico al corpo ecclesiale – all’assemblea riunita – in forza di una funzione ad sacerdotium. La presenza del diacono – soprattutto se accanto al Vescovo – è il segno visibile di quel servizio ad ministerium che, attraverso la cura continuata del corpo ecclesiale in tutti i suoi bisogni, lo prepara e dispone a quella communio che fa delle tante membra una sola assemblea che, unita a Cristo-Capo, celebra «il culto pubblico integrale» (SC 7).
In questo modo, la liturgia eucaristica è «fonte e culmine» del ministero del diacono: dire che «tutte le fatiche apostoliche sono ordinate a ottenere che tutti, diventati figli di Dio mediante il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella chiesa, partecipino al sacrificio e mangino la cena del Signore» (SC 10) vale soprattutto per i diaconi. Il loro ministero, più che una realizzazione di sé, è la manifestazione di una dimensione costitutiva della Chiesa; di ogni Chiesa, che è chiamata ad essere “diaconale”, capace di ascoltare e vedere «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono» (GS 1).
Peraltro, questa modalità di intendere il compito dei diaconi apre all’orizzonte, finora inesplorato, della dimensione carismatica del ministero diaconale. Il Documento Finale del Sinodo ha fortemente insistito sul legame tra carismi e ministeri (cfr DF 57-58). Le tante necessità – del corpo ecclesiale e non solo – in tutti gli ambiti e i contesti di vita, domandano capacità e competenze specifiche, che si acquisiscono certo con una formazione adeguata. Ma lo Spirito, che guida la Chiesa, non manca mai di suscitare doni e carismi per il bene del corpo di Cristo e delle sue membra. Il discernimento sui candidati al ministero diaconale dovrebbe tener conto anche di tale aspetto.
Conclusione necessariamente aperta
Sarà la Chiesa, la vostra Chiesa, nella quale siete incardinati e al servizio della quale siete chiamati, a discernere i “luoghi” e le “urgenze” del vostro servizio, diversi da Chiesa a Chiesa. Ma in ogni luogo e per qualsiasi necessità il gesto che si compie sarà sempre lo stesso: la cura del corpo ecclesiale, che costituisce il proprium del ministero diaconale.
Diaconi, per favore, restituite alla Chiesa la specificità del vostro ministero!
Restituite alla Chiesa il titolo evangelico di Chiesa delle Beatitudini: «Beati voi poveri!» (Lc 6, 20); o quello, equivalente, di Chiesa samaritana, tanto caro a Papa Francesco.
Aiutate la Chiesa, in forza del vostro ministero, a chinarsi su tutte le povertà, a versare su ogni ferita «l’olio della consolazione e il vino della speranza» (prefazio comune VIII).
Passando per la Porta santa, chiedete – chiediamo a Dio di essere questa Chiesa capace di anticipare il banchetto escatologico, perché chiama tutti a sedersi a mensa, restituendo a ciascuno l’abito nuziale.
Passando, il Signore non dovrà dire: «Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?» (Mt 22,12), ma potrà dire:
- Amico, benvenuto nella tua casa! Chi ti ha portato qui?
- Il mio amico diacono, che si è chinato sulle mie ferite, mostrandomi che nella vicinanza della Chiesa che è Madre c’era la tua presenza di Padre… e mi ha dato l’abito per partecipare al banchetto delle Nozze dell’Agnello.
Ite, missa est! Il congedo finale della celebrazione eucaristica, riservato al diacono, non dice che la Messa è finita, ma che, dopo la mensa della Parola e la mensa del Corpo e del Sangue del Signore, continua a un’altra tavola. La formula infatti è composta di due verbi, ite e missa est, con un soggetto sottinteso, l’assemblea stessa che si scioglie, la Chiesa. Ite, [Ecclesia] missa est: Andate, la Chiesa è mandata! Diaconi della Chiesa di Dio, che il vostro ministero, prima e dopo la celebrazione, sia segnoi e strumento capace di far comprendere che, dopo la mensa della Parola e la Mensa eucaristica inizia la Mensa della vita, imbandita con il pane fragrante della carità che voi, più degli altri e come esempio per tutti, siete chiamati a servire.